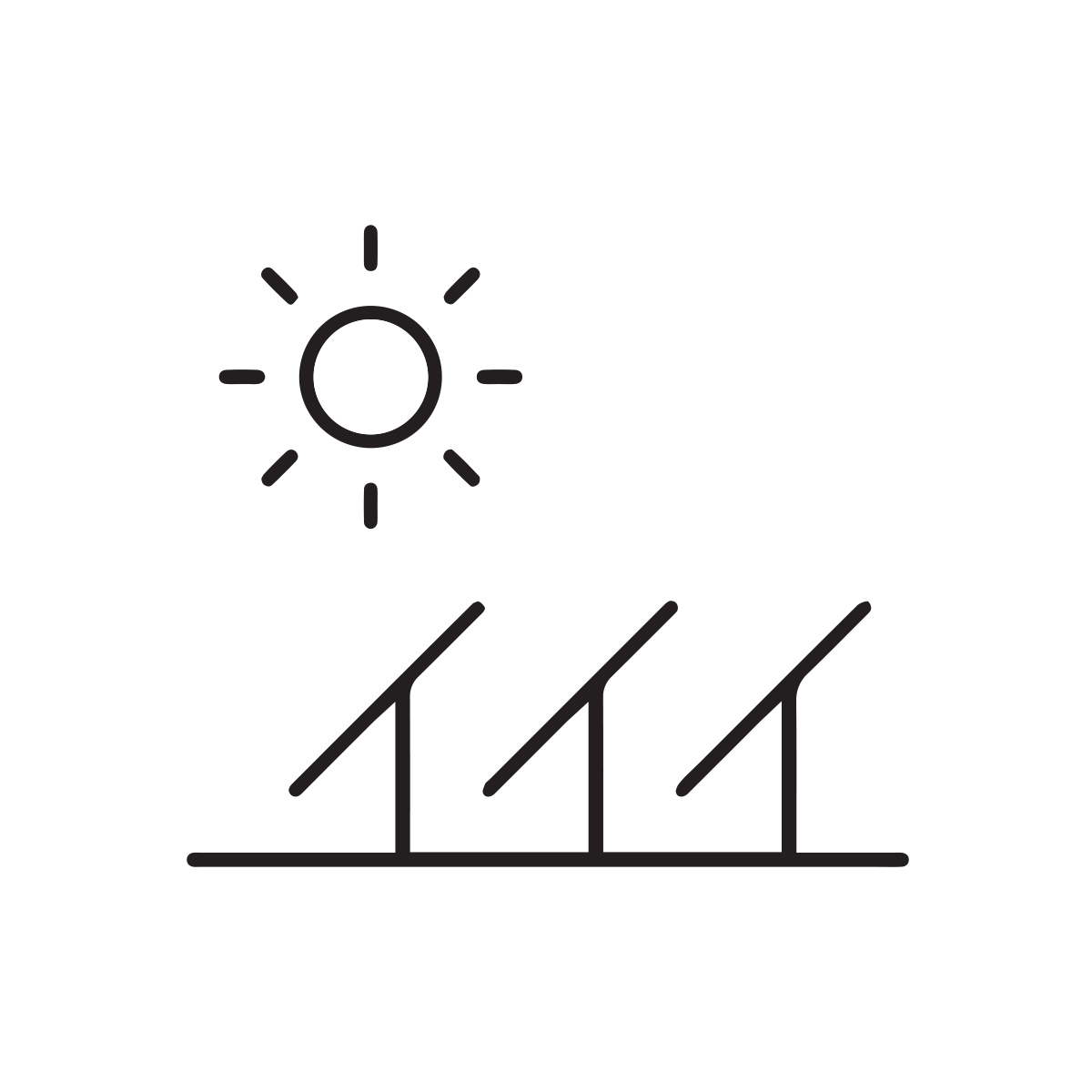Il Sismabonus è un incentivo economico concesso dallo Stato Italiano al fine di rendere gli edifici maggiormente resistenti agli eventi sismici.
La finalità dell’incentivo è quella di mettere in sicurezza il patrimonio di fabbricati esistenti in Italia. Le classi di rischio del patrimonio immobiliare vanno dalla classe A+ (più sicura e antisismica) alla classe G (meno antisismica). L’agevolazione fiscale del Sismabonus è stata introdotta con la legge di bilancio 2017.
Se il fabbricato viene portato a una classe di rischio sismico inferiore rispetto a quella di partenza, l’incentivo dà diritto a una detrazione fiscale pari al 70% delle spese effettuate. Se invece sul fabbricato viene eseguito un intervento che comporta il miglioramento di due classi di rischio sismico, la detrazione passa all’80%. L’intervento può riguardare anche le parti comuni di edifici condominiali, in tal caso, le detrazioni fiscali concesse per il Sismabonus passano rispettivamente al 75 % (in caso di miglioramento di una sola classe di rischio sismico) e all’85 % (in caso di miglioramento di due classi di rischio).
DECRETO RILANCIO 2020
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Con il DECRETO RILANCIO 2020, per gli interventi antisismici eseguiti su edifici condominiali la detrazione di imposta viene elevata al 110% (SuperSismaBonus) indipendentemente dal miglioramento della classe di rischio raggiunto. Per poter beneficiare di questa agevolazione è però necessaria la predisposizione di un apposito visto di conformità, rilasciato da un fiscalista, nonché l’attestazione delle classi di rischio dell’edificio pre e post intervento, secondo le Linee Guida e i modelli predisposte dal M.I.T con il DM 65/2017. Oltre a ciò è indispensabile anche l’attestazione da parte del progettista e della D.L. della congruità dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento.
L’importanza del SismaBonus
E’ pressoché noto che l’Italia è uno dei Paesi con la popolazione più anziana del mondo e anche le nostre abitazioni lo dimostrano. A proposito dello stato di conservazione di questo patrimonio edilizio, l’ISTAT (riferimento censimento del 2011) ci dà questa immagine: il 36,6% delle abitazioni del nostro Paese (11,6 milioni di unità immobiliari) ha più di 40 anni di vita, con picchi del 42% in alcune grandi città.
Più specificamente, circa il 75% del nostro patrimonio edilizio è stato realizzato in assenza di normative antisismiche, la prima delle quali è stata promulgata nel 1974, ma la cui applicazione è giunta a compimento solo tra il 1981 e il 1984.
Questi dati forniscono la dimensione di come il patrimonio edilizio maggiormente diffuso sia perlopiù inefficiente sia energeticamente, ma anche strutturalmente. Tutto ciò, rispetto agli edifici più nuovi, ossia quelli realizzati successivamente alla tragedia dell’Aquila del 2008 e la relativa pubblicazione delle NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni) che tengono conto del rischio di carattere sismico.
Quando si parla di rischio si intende un valore concreto e calcolabile che può essere più o meno elevato poiché esso non è mai pari a zero.
In particolare, il rischio sismico è definito sulla base dei parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione e può essere spiegato come la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al livello di sismicità del sito, alla resistenza delle costruzioni, alla natura e alla qualità e quantità dei beni esposti. Alla luce di ciò, l’Italia è un Paese con un elevato rischio sismico a causa di una pericolosità sismica medio-alta, di una vulnerabilità molto elevata e di un’esposizione altissima.
Onde diminuire il rischio è certamente auspicabile operare sulla riduzione della vulnerabilità, attraverso un’azione sistematica di opere di messa in sicurezza e di miglioramento sismico degli edifici esistenti.
La riduzione della vulnerabilità può essere perseguita sia attraverso l’esecuzione di specifici interventi, finalizzati a rimuovere le criticità (elementi di vulnerabilità) della costruzione sia andando ad aumentare la capacità di resistenza globale della struttura, avendo preventivamente fissato quelli che sono gli obiettivi da raggiungere, in termini di prestazione sismica.
Per poter intraprendere le azioni più corrette è quindi necessario sviluppare un’approfondita analisi finalizzata a comprendere com’è stato realizzato un edificio anche al fine di capire dove sono posizionate le strutture e in quale stato esse si trovino. Devono essere verificati i materiali di cui l’immobile è fatto, nonché definire gli elementi di vulnerabilità. Conoscere il livello di sicurezza iniziale e stabilire quale livello si possa raggiungere, tramite l’intervento da progettare. Non è possibile procedere con una progettazione priva di un’analisi accurata svolta sull’edificio, così come non tutto può essere adattato con successo all’esistente.
Il livello di sicurezza minimo imposto a un edificio è precisamente stabilito dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) del 2018. Tutte le costruzioni realizzate sul territorio nazionale si confrontano con questo standard.
Assumendo il livello di sicurezza minimo di un edificio progettato con i moderni standard normativi pari a 1, l’edificio esistente avrà un valore di sicurezza compreso tra 0 e 1.
L’obiettivo dell’adeguamento sugli edifici esistenti è quello di innalzare il loro livello di sicurezza. Si definiscono quindi interventi di adeguamento:
- tutti quelli che permettono di raggiungere il livello di sicurezza pari o superiore a 1;
- di miglioramento: quelli che incrementano il livello di sicurezza dell’edificio seppur mantenendolo al di sotto dell’unità;
- riparazioni o interventi locali: interessano in genere elementi isolati e che comunque comportano un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti localmente SuperSismaBonus 110%.
Per i singoli interventi, le percentuali di detrazioni fiscali sono pari a:
- 75% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
- 85% delle spese sostenute , sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.
- 110% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, indipendentemente dal miglioramento della classe di rischio SuperSismaBonus 110%.